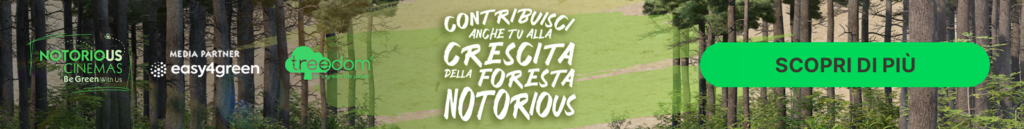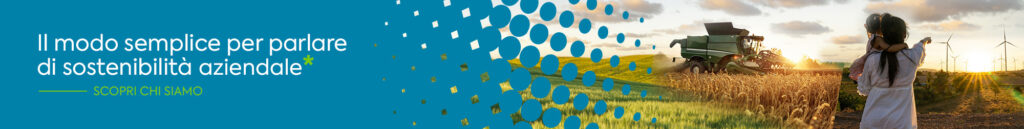Indice
Cos’è l’agricoltura rigenerativa
L’agricoltura rigenerativa è un approccio agricolo innovativo e sostenibile che punta a rigenerare i suoli aumentandone la fertilità e limitando l’erosione, promuovere la biodiversità riducendo le contaminazioni da sostanze chimiche e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici. Questo metodo non si limita a “non danneggiare” il territorio, ma agisce attivamente per migliorarlo e mantenerlo in salute.
Questa pratica si basa su un insieme di tecniche e principi che lavorano in armonia con i cicli naturali, cercando di creare un’agricoltura più equa, duratura e rispettosa degli ecosistemi.
Differenze rispetto all’agricoltura convenzionale e intensiva

L’agricoltura convenzionale, o intensiva, si basa su un uso massiccio di fertilizzanti chimici, pesticidi e grandi quantità di acqua, sfruttando al massimo il terreno a discapito della salute del suolo e del territorio circostante. Queste tecniche portano a elevate emissioni di CO2 e a gravi danni alla biodiversità e agli ecosistemi.
L’agricoltura rigenerativa, invece, si basa su principi ecologici che vogliono salvaguardare il territorio, promuovendo la riduzione dell’uso di sostanze chimiche, la diversificazione colturale, il ripristino della fertilità naturale del terreno e un rapporto più armonico tra uomo e natura.
I principi cardine
L’agricoltura rigenerativa è costruita su 3 principi fondamentali:
- Cura del suolo: Il suolo è un organismo vivente. Proteggerne la struttura e la biodiversità è essenziale per una produzione sostenibile e sana. La rotazione delle colture, il recupero dell’acqua piovana, l’avvento di tecniche alternative all’aratro, l’uso di compost o concimi organici e l’inserimento di colture di copertura aiutano a mantenere il suolo vivo e fertile.
- Promozione della biodiversità: Coltivare più specie insieme, integrare alberi e siepi, favorire la presenza di insetti utili sono tutte strategie per rafforzare la rete ecologica e ridurre la dipendenza da prodotti chimici.

- Resilienza climatica: L’agricoltura rigenerativa aiuta i sistemi agricoli a diventare più resistenti a eventi climatici estremi, migliorando la capacità del suolo di trattenere acqua, assorbire CO2 e mitigare gli impatti del cambiamento climatico.
Benefici dell’agricoltura rigenerativa
L’agricoltura rigenerativa risponde in modo concreto all’Obiettivo 2 dell’Agenda 2030: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare e promuovere un’agricoltura sostenibile. Non si tratta solo di produrre di più, ma di farlo meglio, rigenerando le risorse naturali da cui dipendiamo. I suoi benefici vanno ben oltre il campo coltivato. È un approccio che guarda al lungo periodo, in grado di coniugare sostenibilità ambientale, redditività economica e giustizia sociale.
Miglioramento della salute del suolo

Uno dei principali vantaggi dell’agricoltura rigenerativa riguarda la salute del suolo. Un terreno sano è la base per un’agricoltura duratura e produttiva. Le pratiche rigenerative puntano ad arricchire la sostanza organica presente nel suolo e a stimolare la vita microbica, cioè quell’insieme di microrganismi – come batteri, funghi e lombrichi – che rendono il suolo vivo e fertile.
Inoltre, la riduzione o eliminazione dell’aratura permette di preservare la struttura del suolo e limitare fenomeni come l’erosione e la compattazione, molto comuni nei sistemi agricoli intensivi.
Sequestro del carbonio
Un altro impatto positivo riguarda la capacità dell’agricoltura rigenerativa di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso il sequestro del carbonio. Alcune pratiche agricole, come sottolinea il Carbon Cycle Institute, favoriscono l’assorbimento della CO2 atmosferica e la sua trasformazione in carbonio organico stabile, immagazzinato nel suolo. La logica è semplice: un suolo vivo, ricco di piante con radici profonde e microrganismi attivi, cattura e trattiene molto più carbonio rispetto a un suolo impoverito o intensivamente lavorato. Non si tratta quindi solo di “non inquinare”, ma di migliorare attivamente l’ambiente.
Gestione dell’acqua
Un terreno rigenerato, sano e ricco è più strutturato, ha una maggiore porosità e quindi trattiene meglio l’umidità. Questo significa meno dispersione dell’acqua, minore necessità di irrigazione e una maggiore resistenza a fenomeni estremi come siccità o piogge intense. Infatti, un terreno ricco di sostanza organica è in grado di trattenere quantità di acqua fino a 20 volte il suo peso, riducendo il rischio di erosione e favorendo una maggiore produttività anche in condizioni climatiche avverse.
Benefici economici e sociali
Non è solo una questione ambientale: l’agricoltura rigenerativa può portare anche vantaggi economici e sociali tangibili:
- Redditività nel lungo termine: le aziende che adottano questo approccio tendono a ridurre progressivamente l’uso di input chimici, come fertilizzanti sintetici e pesticidi, con un risparmio economico importante. Inoltre, un terreno più sano e fertile garantisce raccolti più stabili nel tempo, anche in condizioni climatiche difficili, riducendo il rischio d’impresa. Uno studio di EARA (European Alliance for Regenerative Agricolture) ha dimostrato che le aziende agricole rigenerative ottengono mediamente una produttività del 27% in più rispetto a quelle convenzionali.
- Valorizzazione del lavoro agricolo: chi sceglie la rigenerazione sviluppa un rapporto diretto con la propria terra, riduce la dipendenza da fornitori esterni e impara a gestire il suolo come una risorsa preziosa, diventando più autonomo e resiliente.
- Coinvolgimento delle comunità: spesso, chi adotta pratiche rigenerative sceglie anche di aprirsi alla comunità, organizza mercati locali, laboratori didattici, momenti di formazione e condivisione, rafforzando il legame con il territorio e promuovendo modelli di consumo consapevoli.
Pratiche e tecniche usate
La rotazione delle colture
La rotazione è una pratica millenaria che consiste nell’alternare diverse colture sullo stesso campo, secondo una logica stagionale o pluriannuale.
Questa tecnica aiuta a:
- Ridurre la pressione di parassiti e malattie
- Migliorare la fertilità del suolo
- Stimolare la biodiversità vegetale e microbica
Alternare cereali, ortaggi e legumi può migliorare le rese nel medio periodo, riducendo la necessità di fertilizzanti e antiparassitari.
Pratiche di agroforestazione e policoltura
L’agroforestazione è l’integrazione di alberi e arbusti nelle coltivazioni o nei pascoli. È una tecnica che replica gli equilibri delle foreste naturali.
Gli alberi offrono ombra, migliorano il microclima, proteggono dal vento, arricchiscono il suolo con foglie e radici. Colture diverse possono coesistere nello stesso spazio, aumentando la produttività per ettaro. In Italia, l’agroforestazione trova applicazione in vigneti con alberature laterali, oliveti misti a ortaggi o frutteti integrati.

Una versione di questa tecnica è il cover cropping, che prevede una coltivazione del terreno costante, anche durante i mesi invernali, durante i quali si possono far crescere colture non destinate alla raccolta ma che aiutano a proteggere dall’erosione del suolo.
Compostaggio e uso di ammendanti organici

Il compostaggio è un processo naturale che trasforma residui vegetali e scarti organici in un fertilizzante ricco di sostanza organica. L’uso del compost aiuta a nutrire il suolo, migliorarne la struttura e stimolare l’attività biologica.
Gli ammendanti organici, come letame maturo, digestati o humus di lombrico, sono fondamentali per rigenerare suoli impoveriti e restituire alla terra ciò che le viene tolto con i raccolti.
Il contributo del biofertilizzante (ammendanti biologici) in agricoltura rigenerativa, porta benefici non solo a livello agronomico ma anche dal punto di vista del profilo qualitativo delle produzioni.
Tecniche di non lavorazione del suolo (no-till farming)
Il metodo del no-till, o “non lavorazione del suolo”, consiste nel seminare direttamente sul terreno non arato. Questa tecnica evita la rottura della struttura del suolo, protegge la sua superficie e favorisce la vita microbica.
Con il no-till si riduce l’erosione, si limita l’evaporazione dell’umidità e si conserva meglio il carbonio organico nel terreno. Inoltre, si risparmiano risorse energetiche legate all’uso di mezzi meccanici pesanti, riducendo i costi per l’azienda agricola.
Carbon farming
Tra le pratiche più promettenti, il carbon farming applicato a diverse colture agricole offre un’opportunità concreta per migliorare la sostenibilità delle filiere agricole Italiane, favorendo l’incremento dello stock di carbonio nei suoli e rafforzando la resilienza dei sistemi agricoli ai cambiamenti climatici. Al contempo questa pratica potrebbe portare nuove prospettive di sviluppo economico al settore collegate alle evoluzioni in corso del mercato dei crediti di carbonio.

A livello europeo, il Green Deal e la nuova PAC (Politica Agricola Comune) tracciano un percorso chiaro verso modelli di agricoltura rigenerativa, incentivando pratiche che migliorano la salute del suolo e favoriscono la riduzione delle emissioni di gas serra o l’aumento degli assorbimenti di carbonio. L’iniziativa sul Carbon Farming della Commissione Europea inquadrata all’interno del Carbon Removals and Carbon Farming (CRCF) Regulation (EU/2024/3012), recentemente adottata, mira a promuovere e regolamentare l’adozione di sistemi produttivi che sequestrano carbonio in modo misurabile e verificabile, creando opportunità economiche per gli agricoltori attraverso la vendita di crediti di carbonio.
In tale contesto, attraverso un approccio pratico e basato su dati scientifici, questi progetti mirano a supportare le aziende agricole nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili, favorendo al contempo nuove opportunità di reddito attraverso i mercati emergenti del carbonio.
Ivano Assenza, Regenalia
L’agricoltura rigenerativa è una realtà in crescita. Con oltre il 20% della SAU italiana in biologico (ISMEA, 2024), molte aziende stanno evolvendo verso modelli rigenerativi.
La PAC 2023–2027 sostiene questa transizione con eco-schemi dedicati, mentre il nuovo Regolamento Europeo CRCF (EU/2024/3012) riconosce ufficialmente il carbon farming come strumento per il sequestro certificato di carbonio.
Come sottolinea la Commissione Europea, questi sistemi offrono nuove prospettive economiche per gli agricoltori, integrando reddito tramite i mercati emergenti dei crediti di carbonio.
Certificazioni per l’agricoltura rigenerativa
Se ti stai chiedendo se esistono certificazioni che garantiscano davvero un’agricoltura rigenerativa, la risposta è sì. E anche in Italia ci sono già realtà che le adottano. Ecco le principali da conoscere:
- Regenerative Organic Certified® (ROC™)
È la certificazione più completa e riconosciuta a livello internazionale per l’agricoltura biologica rigenerativa. Si basa su salute del suolo, benessere animale ed equità sociale.
Promossa dalla Regenerative Organic Alliance (ROA), è attiva anche in Europa e in Italia grazie a enti certificatori come ICEA, che accompagnano le aziende nel percorso di transizione.
- FoodChainID
Si tratta di uno standard volontario, pensato per aziende che vogliono valorizzare il proprio impegno in campo ambientale e include criteri come: protezione del suolo, cover cropping, riduzione di input chimici, aumento della biodiversità e miglioramento della sostanza organica del suolo. È adatto a chi vuole iniziare un percorso rigenerativo e comunicare con trasparenza il proprio impegno. - Organismi di controllo biologico
In Italia esistono numerosi enti di controllo per l’agricoltura biologica (come ICEA, Bioagricert, CCPB, Codex, Suolo e Salute), e molti di questi supportano anche pratiche rigenerative, pur senza un’etichetta ufficiale. - Certificazioni che possono generare crediti di carbonio in ambito carbon farming: agevolare la filiera circolare permettendo gli agricoltori di utilizzare schemi di incentivi (oltre alla PAC) per la transizione ecologica agricola e di conseguenza ridurre l’impatto ambientale su tutta la filiera (dalla produzione alla vendita).
La situazione in Italia
Secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), circa un terzo delle emissioni globali di gas serra è legato ai sistemi alimentari. Solo nell’Unione Europea, l’agricoltura è responsabile di quasi l’11% delle emissioni, dovute in gran parte al metano prodotto dagli allevamenti e al protossido di azoto che si sprigiona dai suoli coltivati.
Ma se allarghiamo lo sguardo all’intera filiera agroalimentare (dalla produzione alla trasformazione e i trasporti, fino al consumo) il peso cresce ancora: si stima che a livello globale il settore generi circa il 22% delle emissioni totali, mentre in Europa incide per il 9% e in Italia per circa il 7%.

Alla luce di questi dati, è chiaro che ripensare il modo in cui coltiviamo è una priorità. Per questo, l’agricoltura rigenerativa sta guadagnando terreno anche nel nostro Paese. Sempre più aziende agricole stanno scegliendo di lavorare la terra in modo diverso, spesso partendo da esperienze nel biologico o nel biodinamico, e integrando pratiche rigenerative.
E oggi, anche il contesto è favorevole: il nuovo Piano Strategico della PAC 2023–2027 sostiene la transizione ecologica dell’agricoltura con incentivi concreti per chi adotta metodi più sostenibili, per accompagnare le aziende nel cambiamento.
Esempi reali
Ecco tre esempi virtuosi che mostrano come si possa coltivare in modo rigenerativo, rispettando la terra e ottenendo prodotti di qualità.
Podere Cimbalona – Faenza, Emilia-Romagna
Nel cuore della Romagna, Daniele e Sara coltivano frutta, ortaggi e vite su sei ettari con un approccio che unisce passione e rigenerazione. Al Podere Cimbalona si lavora la terra il meno possibile, si usano pacciamature naturali, cover crop e sovesci per arricchire il suolo, e persino le galline partecipano al processo, grazie al pascolo razionale. Un ecosistema in equilibrio, dove la fertilità del suolo cresce stagione dopo stagione.
La Torre alle Tolfe – Siena, Toscana
Azienda di 50 ettari tra vigneti, oliveti, campi coltivati e boschi che segue i principi dell’agricoltura rigenerativa, concentrandosi sulla conservazione e riabilitazione dei sistemi agricoli. Usa colture di copertura e sovesci per ridurre erosione e competizione idrica, incrementando biodiversità e attività microbica nel suolo.
LENs – Landscape Enterprise Networks (Veneto e Friuli-Venezia Giulia)
Progetto promosso da Purina che coinvolge oltre 50 aziende agricole (familiari e di varie dimensioni) per adottare pratiche rigenerative come colture di copertura, minima lavorazione del suolo, gestione dei nutrienti e interventi per la biodiversità. Il network ha raggiunto più di 2000 ettari coltivati con metodi rigenerativi.
Regenalia – “Dare forza alla natura e agli agricoltori”
Fondata da Ivano Assenza, con esperienza internazionale in ClimatePartner, Regenalia accompagna aziende agricole e filiere agroalimentari italiane nella transizione rigenerativa attraverso il carbon farming e l’insetting. I progetti si basano su metodologie scientifiche riconosciute a livello europeo per la generazione di crediti di carbonio certificati. Regenalia offre supporto completo – dalla formazione iniziale alla progettazione e implementazione – valorizzando il ruolo centrale degli agricoltori e creando filiere circolari dove ogni attore contribuisce alla rigenerazione del suolo, alla riduzione delle emissioni e alla creazione di nuove opportunità economiche.

L’agricoltura rigenerativa rappresenta molto più di un insieme di tecniche agricole: è un cambio di paradigma, un invito a coltivare in modo più etico, resiliente e connesso con la Terra. Sceglierla, sostenerla e raccontarla è un modo per costruire insieme un futuro più verde, sano e giusto. Per tutti. Anche per chi, della Terra, non ne ha mai toccato una zolla.